La filosofia dell’unicorno
La filosofia dell’arte procede in larga misura per deformazione logica e forzature ermeneutiche basate su supposizioni. Anziché descrivere le opere il filosofo dell’arte le interpreta, riconducendole alle proprie aprioristiche convinzioni. Uno degli espedienti abituali consiste nel contestualizzare, quasi che il contesto abbia il potere di mutare significato e sostanza. Un asino è un asino in qualunque luogo o situazione collocato. La contestualizzazione ambientale e storica non ha il potere di modificare l’ontologia , come pretendono molti filosofi dell’arte. Se noi collochiamo un’opera di Cesar in un deposito di ricuperi ferrosi, essa si confonde con il resto dei materiali, così come l’orinatoio di Duchamp riportato in un magazzino di apparati igienici. La contestualizzazione è dunque un’efficace espediente che, insieme alle forzature ermeneutiche , attua il tentativo di modificare l’ontologia dell’oggetto. Far credere che l’ottone sia oro non è abilità, è inganno. Dunque oggetti la cui ontologia è affidata al contesto, non possono essere considerate opere d’arte nonostante le spurie teorie che sostengono il contrario. Attraverso la parafrasi proposta da Russel, l’enunciato , il cui predicato non è formulato secondo le proprietà dell’oggetto, è un anacoluto logico e grammaticale. Un nome , nel senso ristretto di denominazione di un oggetto, non comporta di necessità la conoscenza. Il concetto semantico deve avere una fondazione epistemologica, basata sulla distinzione tra conoscenza diretta e conoscenza per descrizione. Ogni formulazione filosofica, dovrebbe partire da un riconoscimento formale e materico e quindi pervenire a una conoscenza diretta dell’oggetto, quale è realmente. S’indugia invece in forme metafisiche attribuendo all’artista il potere di modificazione ontologica con il semplice atto di scelta. La forma logica di un enunciato del linguaggio deve avere riscontro con la realtà sostanziale. Le presunte intuizioni dell’artista, in base alle quali il filosofo dell’arte formula teorie e giudizi, non sono che opinioni che nascono da un percorso epistemologico viziato dal pregiudizio, le distinzioni, e formulazioni arbitrarie che ne conseguono, sono un formidabile esempio di manipolazione del linguaggio su errati presupposti ontologici. Russell era consapevole di questo quando sosteneva che “un robusto senso della realtà è indispensabile per un uso corretto del linguaggio,perché la logica non può ammettere l’esistenza di un unicorno più di quanto lo possa la zoologia”.
piergiorgio firinu 



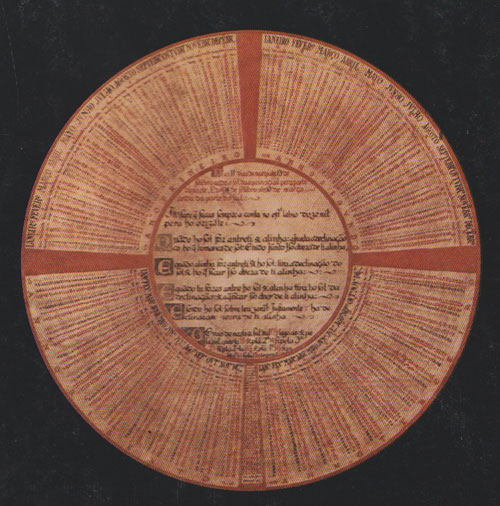

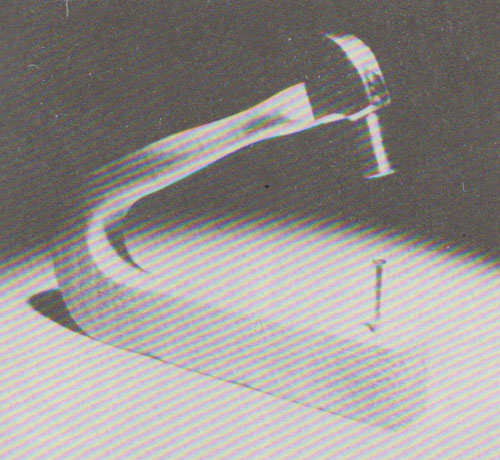
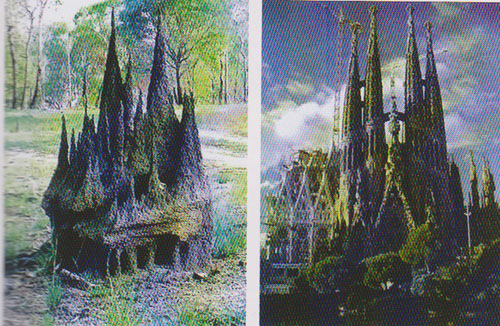
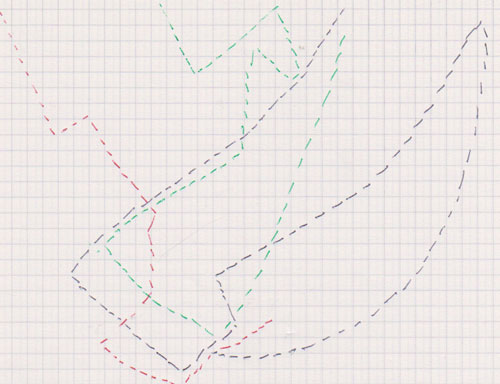







Commenti recenti