Forse non è il cervello il vero luogo della evoluzione umana, Gaston Bachelard si pone la domanda ma resta vago nella risposta. Il germoglio terminale dello slancio Vitale con le sue molteplici connessioni, non ha forse dell’organo delle innumerevoli possibilità quando adopera la suggestiva espressione di campi di forza creati nell’immaginazione dallo spostamento di due immagini diverse, non ci spinge forse, in un certo senso, a dinamizzare i rapporti delle idee e conferire all’idea forza un senso sempre più pregnante? Allora tutto è ormai definito, l’anima, corpo, persino il mondo nel quale cerchiamo di oggettivare la nostra esistenza. Le grandi nobili suggestioni che inducono a confrontarci con una realtà globale che l’artista ritornerebbe a trovare con gioia in una filosofia originale del creare al fine di comprendere l’evoluzione intellettuale e farla propria. Converrebbe prestare attenzione al pensiero, sempre alla ricerca di occasioni dialettiche, per uscire dai propri confini, rompere i propri quadri, insomma, il pensiero che tenta di oggettivarsi. Allora non è possibile concludere che un tale pensiero sia creatore? Che sia la spinta psicologica che guida? E’ un fatto che spesso le idee più ardite, feconde, sono dovute a artisti e scienziati giovanissime dei quali potremmo fare un lungo elenco a partire da Antoine-Laurent de Lavoisier, ghigliottinato durante la rivoluzione francese del 1789, per finire a Albert Einstein che scopri la relatività ristretta a 25 anni. L’elenco di artisti che dettero il meglio di se prima dei trent’anni sarebbe ancor più lungo A confronto della realtà contemporanea nella quale i giovani sembrano sempre alla ricerca di supporti e giustificazioni. L’idea che possa esistere una intuizione creativa trova conforto nella giovane età di artisti e scienziati che, per ragioni biografiche, non potevano avere ne molta esperienza e neppure ampia conoscenza. I filosofi si sono cimentati nel tentativo di indagare la creatività. Martin Heidegger in “L’origine dell’opera d’arte”(1950) , nel suo stile di scrittura piuttosto tortuoso, ha esaminato il rapporto dell’artista con l’opera e dell’opera con l’artista. Non pare abbia gettata luce utile per chiarire il problema. Risultato non migliore ha ottenuto Edward O. Wilson con “Le origini della creatività”(2017) che ha posto l’accento sull’uso delle metafore. In breve l’essere umano, i suoi pensieri, la creatività restano oscure ombre in fondo alla mente che cerca di conoscere la natura, ma ha difficoltà a capire se stessa. 
Considerazioni sull'arte


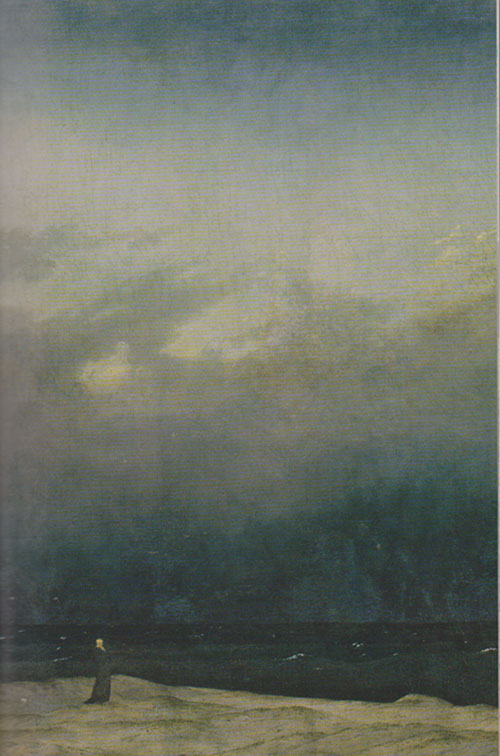


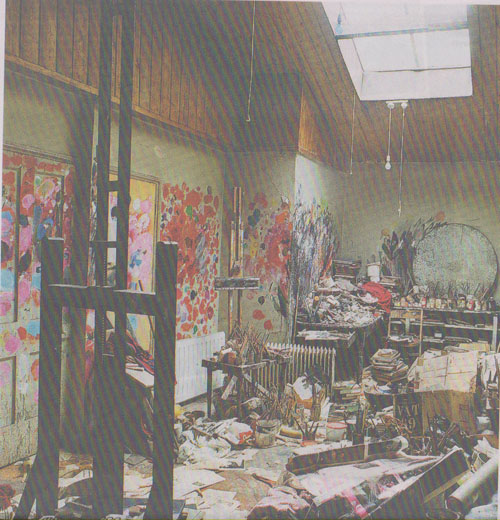


 La lunga diatriba tra ottimisti e pessimisti è una delle tante questione che non ha trovato conclusioni. Non c’è dubbio che il pessimismo di molti filosofi sia ampiamente giustificato. Proprio in questo periodo, con il Codice 19 abbiamo un esempio di come le calamità possono colpire gli esseri umani. Il concetto di ottimismo è stato creato dall’uomo per descrivere un proprio stato d’animo. Sono molti i filosofi antichi e moderni che hanno affrontato il tema. Eraclito, Empedocle, Pitagora, Platone, ed anche narratori e scrittori di tragedie, Orfeo, Pindaro, Erodoto, Euripide, per limitarci agli antichi. Questi creatori d’immaginazione e di miti che hanno indugiato sul pessimismo, forse per ragioni personali oppure perché il periodo storico che vivevano suggeriva tale stato d’animo. Infatti l’ermeneutica della realtà, anche degli uomini di cultura, è condizionata dalla proprie emozioni. La vita, l’universo, la natura, non sono ne pessimisti ne ottimisti, sono semplicemente regolati da processi spontanei in base ai quali si produce la vita e la morte di tutto ciò che di vitale esiste sul nostro pianeta. La questione è in parte affrontata nel trattato di filosofia naturale scritto nel 1969 da Jacques Monod, dal titolo: “ Il caso e la necessità”. A parte i processi biologici, fonte della vita sulla terra, se osserviamo il nostro pianeta in una prospettiva planetaria, ci rendiamo conto che esso è ben poca cosa, un insignificante punto nello spazio. Dovremmo dunque ammettere che scienza, cultura, arte, sono frammenti insignificanti nell’economia dell’universo. Tutto il nostro sapere ha i limiti della nostra intelligenza ed ha necessariamente come riferimento noi stessi e il nostro pianeta. La natura che ci circonda contiene in se stessa la forza che la fa esistere e la distrugge. Qual è la ragione per la quale la gazzella è cibo per il leone? Attraverso ciò che definiamo “cultura” noi abbiamo modificato leggi della natura e abbiamo dato un’impronta alla società che spesso calpesta l’etica, con la nostra scienza improntata al solipsismo, abbiamo distrutto milioni di esemplari di fauna e di flora. La nostra presuntuosa arroganza va ben oltre la nostra intelligenza, tanto che ci stiamo rendendo conto dei disastri provocati ma non vogliamo, o forse non possiamo porre rimedio. Quasi tutti i filosofi, in primis Spinoza , al termine dei loro ragionamenti concludono: come volevasi dimostrare. In realtà le parole non dimostrano proprio nulla, se mai ipotizzano, presumono, immaginano. Anche l’immaginazione umana finisce per essere codificata. L’arte, specie dopo la deriva delle avanguardie, si è tradotta in forme espressive la cui essenzialità e significato sono affidati alla fantasia dei critici e dei filosofi dell’arte i quali costruisco castelli di parole che collidono con la realtà che abbiamo sotto i nostri occhi. Parafrando il noto detto di Gramsci potremmo dire che si affidano all’ottimismo della presunzione.
La lunga diatriba tra ottimisti e pessimisti è una delle tante questione che non ha trovato conclusioni. Non c’è dubbio che il pessimismo di molti filosofi sia ampiamente giustificato. Proprio in questo periodo, con il Codice 19 abbiamo un esempio di come le calamità possono colpire gli esseri umani. Il concetto di ottimismo è stato creato dall’uomo per descrivere un proprio stato d’animo. Sono molti i filosofi antichi e moderni che hanno affrontato il tema. Eraclito, Empedocle, Pitagora, Platone, ed anche narratori e scrittori di tragedie, Orfeo, Pindaro, Erodoto, Euripide, per limitarci agli antichi. Questi creatori d’immaginazione e di miti che hanno indugiato sul pessimismo, forse per ragioni personali oppure perché il periodo storico che vivevano suggeriva tale stato d’animo. Infatti l’ermeneutica della realtà, anche degli uomini di cultura, è condizionata dalla proprie emozioni. La vita, l’universo, la natura, non sono ne pessimisti ne ottimisti, sono semplicemente regolati da processi spontanei in base ai quali si produce la vita e la morte di tutto ciò che di vitale esiste sul nostro pianeta. La questione è in parte affrontata nel trattato di filosofia naturale scritto nel 1969 da Jacques Monod, dal titolo: “ Il caso e la necessità”. A parte i processi biologici, fonte della vita sulla terra, se osserviamo il nostro pianeta in una prospettiva planetaria, ci rendiamo conto che esso è ben poca cosa, un insignificante punto nello spazio. Dovremmo dunque ammettere che scienza, cultura, arte, sono frammenti insignificanti nell’economia dell’universo. Tutto il nostro sapere ha i limiti della nostra intelligenza ed ha necessariamente come riferimento noi stessi e il nostro pianeta. La natura che ci circonda contiene in se stessa la forza che la fa esistere e la distrugge. Qual è la ragione per la quale la gazzella è cibo per il leone? Attraverso ciò che definiamo “cultura” noi abbiamo modificato leggi della natura e abbiamo dato un’impronta alla società che spesso calpesta l’etica, con la nostra scienza improntata al solipsismo, abbiamo distrutto milioni di esemplari di fauna e di flora. La nostra presuntuosa arroganza va ben oltre la nostra intelligenza, tanto che ci stiamo rendendo conto dei disastri provocati ma non vogliamo, o forse non possiamo porre rimedio. Quasi tutti i filosofi, in primis Spinoza , al termine dei loro ragionamenti concludono: come volevasi dimostrare. In realtà le parole non dimostrano proprio nulla, se mai ipotizzano, presumono, immaginano. Anche l’immaginazione umana finisce per essere codificata. L’arte, specie dopo la deriva delle avanguardie, si è tradotta in forme espressive la cui essenzialità e significato sono affidati alla fantasia dei critici e dei filosofi dell’arte i quali costruisco castelli di parole che collidono con la realtà che abbiamo sotto i nostri occhi. Parafrando il noto detto di Gramsci potremmo dire che si affidano all’ottimismo della presunzione.






Commenti recenti